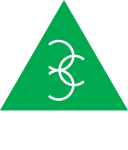Per il nuovo film Netflix prodotto di Ryan Murphy, The boys in the band, presta la voce a Jim Parsons, uno dei protagonisti. Per questo da Emiliano Coltorti ci siamo fatti raccontare qualcosa di più su questa storia diretta da Joe Mantello. A partire dalla peculiarità che salta agli occhi a prima vista: essendo un film con storie omosessuali sono anche omosessuali tutti gli attori coinvolti. Un’operazione anti-appropriazione culturale, quasi una questione di quote bloccate.

«Da attore, da bambino-adulto che passa la vita a giocare, e che usa la fantasia quindi usa qualcosa che per definizione non ha limitazioni, secondo me ha molto poco senso dire “qui devo fare un personaggio omosessuale quindi prendo un attore omosessuale, oppure ho bisogno di un tombeur de femmes per interpretare uno scopatore” secondo me non è così che di base funziona la recitazione, quindi non la reputo – istintivamente – una scelta necessaria. D’altro canto, parlando con colleghi e attori omosessuali, devo ammettere che anche un’altra posizione ha senso. Dicono: “ci sono attori molto famosi, le superstar hollywoodiane, che cannibalizzano ogni tipo di ruolo. Se la star è donna ma il protagonista del film è un uomo lo si trasforma in donna pur di dare la parte alla diva di turno e così via. In questo modo ci sono attori che si vedono scippati anche solo della possibilità di essere inclusi nella rosa di eventuali interpreti. Allora magari nel caso in cui ci sia un aspetto particolare da raccontare – come per The boys in the band, l’omosessualità – forse allora ha senso usare questo vissuto.” In fondo non so schierarmi da una parte o dall’altra.
Penso che bisognerebbe fare attenzione a mantenere il più possibile un’eterogeneità della classe attoriale, ma non può essere la ‘quota’ – rosa o omosessuale che sia – a discriminare nella scelta degli interpreti, significherebbe la fine di questo mestiere secondo me. Se devi inscenare un ricco ti serve un attore ricco…. Non si può fare secondo me.
Per quanto riguarda il film, The boys in the band è una commedia, con ritmi serrati, battute taglienti, ma sottostante a tutto ci sono amarezza e dolore che in alcuni momenti esplodono. Hanno fatto un lavoro molto bello perché sono riusciti a costruire due piani paralleli che si intersecano e vanno avanti. Uno più superficiale e leggero e uno nascosto, che sono antitetici, come nella vita: in cui tu stai a duemila, sei contento, esci, festeggi ma magari convivi con un tuo dolore, un tuo trauma, una realtà che c’è, ma non è sempre immediatamente evidente per chi ti osserva da fuori.

È tratto da una pièce teatrale ambientata nel ’68, in un momento in cui la condizione degli omosessuali era decisamente difficile, per cui c’è di fondo un gigantesco dolore che tutti questi personaggi in modi differenti si portano dietro, che è il dolore di non essersi accettati, la rabbia di doversi difendere, la paura di mostrarsi, la ghettizzazione… ma rimane dietro alle battute, alla sagacia, alla alle vocine stridule, che contribuiscono a dare profondità e verità alla storia. È una cosa che ho amato molto. Nella regia e anche nella recitazione, nel montaggio, nelle inquadrature poi, c’è qualcosa di molto teatrale, anche se incastonato correttamente nella forma cinematografica.
È un film di parola e sicuramente questo lo espone a critiche per il doppiaggio, ma non bisogna dimenticare che il doppiaggio è di per sé un compromesso, lo stesso dei libri tradotti. E di per sé non c’è niente di sbagliato in questo, perché è un’operazione culturale. Ovvio che il prodotto finale non potrà mai essere lo stesso film dell’originale, ma al tempo stesso se il doppiaggio è fatto bene – e dovrebbe essere questo il fulcro del discorso e di queste stupide diatribe doppiaggio sì/doppiaggio no – è una possibilità di scelta in più.
Su The boys in the band è stato fatto un gran bel lavoro, anche dalla direttrice Lorena Bertini, l’ho visto da spettatore e penso sia venuto fuori bene. Le voci sono molto diverse fra loro, mai macchiettistiche o finte, si incollano molto bene sui personaggi, dietro la recitazione si sente la verità. E dopo 25 anni che faccio il doppiatore penso di avere voce in capitolo!»